|
Qualcosa da sapere sui cavi e non solo.
La trattazione che segue è
frutto di decenni di esperienza valutativa e non il risultato di uno studio
compiuto isolandosi in una “torre d’avorio”. Nel progettare amplificatori,
acustiche o cavi, è richiesta la considerazione di tutti i dati empirici
rilevati, siano questi derivati da test strumentali, di laboratorio, siano
recepiti dai nostri sensi (vista o udito). Le soluzioni, le risposte, provengono
dalla consapevolezza complessiva su ciò che è comprensibile e, soprattutto, su
ciò che non lo è. Sappiamo che non c’è totale identità di vedute su questo
argomento all’interno della comunità audio (e video). Da un lato ci son quelli
che credono ciecamente solo nei test di laboratorio. All’opposto quelli che
ascoltano, o vedono, una limitata selezione di modelli sulla quale sviluppare
confutabili teoremi. La mancanza di un corretto approccio scientifico su i
criteri di valutazione è spesso la causa per cui una fazione sbeffeggia l’altra
per le proprie convinzioni e viceversa. I progetti audio (e video) più validi
appartengono a coloro i quali hanno tenuto conto di tutti i fatti evidenziati, a
prescindere da come siano stati misurati o compresi. Addentrandoci un po’ nel
nostro specifico, potremmo dire – visto da un profano - nulla potrebbe sembrare
più semplice: prendi un segnale - audio o video, digitale o analogico - e lo
trasporti da un posto ad un altro, senza tante complicazioni. La verità vera è
naturalmente un’altra, ed è che ogni cavo deve trasferire – da un componente ad
un altro - un complesso segnale multi ottava senza cambiare nulla
dell’informazione trasportata.“Fare meno danni possibile”, questa è la missione.A noi tutti piace descrivere quanto un buon apparecchio migliori le prestazioni
del nostro impianto; facciamo considerazioni perfettamente legittime e
comprensibili. Però, in queste considerazioni è celato un equivoco concettuale
che nasce dal fatto che un componente di qualità superiore che va a sostituire
uno meno performante, possa effettivamente migliorare il segnale proveniente
dalla sorgente. In certe aree del processo digitale questo è possibile, ma nel
mondo del segnale analogico ciò non può accadere; il segnale si può solo
peggiorarlo. La sostituzione con un componente di qualità superiore migliora il
suono di un impianto solo perché questi provoca meno danni al segnale. I cavi,
come tutti gli altri componenti, dovrebbero essere scelti affinché arrechino il
minimo danno. Il “danno” è rintracciabile in due fondamentali forme: la prima è
una relativamente innocua perdita di informazione; la seconda è l’influenza sul
“carattere”del segnale. Un’analogia può illustrare meglio questa distinzione.
Prendiamo, ad esempio, una lastra di vetro perfettamente pulita. Associandola ad
un componente audio, partiamo dal presupposto che nessun apparecchio è perfetto.
Per coerenza all’esempio della lastra di vetro, consideriamo che essa possa
essere affetta da una leggera dominante grigia. Una qualità più bassa
dell’apparecchio potrebbe essere paragonata ad una dominante grigia più intensa.
Queste varianti di densità del grigio possono rappresentare i vari gradi di
perdita di informazione. Se invece il vetro presenta dominanti tendenti al
verde, al giallo o al rosso, queste tonalità rappresentano una “deviazione” nel
carattere. Statisticamente parlando, è di gran lunga più probabile notare la
leggera dominante colorata, piuttosto che un grigio più scuro. Questo è il
meccanismo del “carattere-contro-quantità” che causa molta confusione nella
ricerca della migliore prestazione.
I luoghi comuni e qualche bugia
Tutti conosciamo l’assunto che recita: “una catena è forte quanto il suo anello
più debole”. Ciò è vero se parliamo di una catena reale, ma diventa una bugia
fuorviante se applicato al mondo dell’audio. La qualità del suono proviene dai
diffusori acustici e la qualità dell’immagine dal monitor TV. Entrambe sono
compromesse da un certo grado di distorsione introdotto da ogni componente la
catena di riproduzione, a partire dal microfono o dalla cinecamera usati per
registrare l’evento reale. Usare la logica è sempre un buon metodo e in questo
caso è molto semplice: ogni componente è decisivo! Le elettroniche, le
acustiche, i cavi, anche ogni saldatura o connettore, tutto può arrecare danno.
Ogni componente è come un velatura sul pannello di vetro, ogni aggiunta
impedisce ulteriormente la vista. La qualità della prestazione finale – la
chiarezza della visione - è il segnale originale, meno il danno prodotto da
tutti gli elementi presenti nel percorso del segnale. Migliorando uno degli
elementi, migliorerà la prestazione. Togliendo uno dei veli dal pannello di
vetro, avremo una visione più chiara. Comprendendo che la sfida è ridurre gli
aspetti negativi e prevenire la distorsione, si può arrivare più facilmente a
capire i miglioramenti “inesplicabili”. Se poi la lastra di vetro non fosse solo
“sporca”, ma anche colorata di rosso, rimuovendo entrambi la “vista”della musica
sarebbe migliorata come era negli auspici. Comunque, il rosso, e la
consapevolezza di quel rosso, non saranno eliminate fino a che l’ultimo velo di
colore non sia stato rimosso. Rimuovendo l’ultimo velo di colore si coglierà una
differenza maggiore di quanto accaduto togliendo gli strati di colore
precedenti. Ci colpisce di più l’eliminazione della dominante rossa, piuttosto
che la precedente riduzione della densità della dominante stessa. Se non
volessimo più sentire il rumore del traffico, esso andrebbe ridotto da tre auto
per minuto a zero auto. Operazione più efficace rispetto a ridurre il flusso
delle auto da nove a sei per minuto. Le persone sono più sensibili alla
manifestazione di un fenomeno, piuttosto che alla sua entità. E’ un risultato
sorprendente! Ci aspettiamo 1+1=2 e ci troviamo 1+1=3. Questo fenomeno è spesso
chiamato "sinergia”. Talvolta siamo di fronte a dei fatti empirici che
semplicemente non riusciamo a comprendere. Comunque, la mancanza di comprensione
non implica che il fenomeno sia sovrannaturale o incomprensibile. Se qualcosa è
troppo distante per essere vista, non significa che questa distanza sia
infinita. Allestire o migliorare un impianto in modo utile a massimizzare le
prestazioni, richiede una grande capacità di visione ed un affidabile criterio
di valutazione. Ben combinati, questi fattori rendono il processo godibile ed
affidabile.
Le problematiche dei caviL’”effetto pelle” è uno dei problemi fondamentali che affligge i cavi. E’
normale pensare ad un conduttore metallico come una sorta di “binario”. Il
potenziale elettrico è trasferito in forma di corrente nel conduttore metallico
e come, campo magnetico, fuori dal conduttore stesso. L’uno non può esistere
senza l’altro. L’unico punto in cui entrambi, campo magnetico e densità di
flusso della corrente sono al 100%, è sulla superficie del conduttore. Il campo
magnetico esterno diminuisce aumentando la distanza dal conduttore, mentre la
densità di flusso della corrente è al 100% solo sulla superficie di questi.
Qualcosa del genere accade anche all’interno del filo elettrico. L’”effetto
pelle” sta a significare una diminuzione della densità di flusso della corrente,
con l’aumentare della distanza dalla superficie verso l’interno. C’è una
soluzione per combattere l’”effetto pelle”, ed è quella che prevede l’uso di un
conduttore singolo sufficientemente piccolo da espellere fuori della gamma audio
la distorsione udibile indotta dall’“effetto pelle” stesso. La semplice
valutazione di conduttori di diversi diametri rivela che le udibili anomalie
indotte dall’”effetto pelle” cominciano già con conduttori non più grandi di 0.8
mm. La superficie di un grosso conduttore è un buon percorso per il segnale
quanto lo è quella di un conduttore sottile; solo che il conduttore grosso ha
anche un nucleo che conduce differentemente. Nei cavi con conduttori grossi e
rettilinei e con quelli più sottili con un percorso più lungo, la via più facile
per le alte frequenze è, in effetti, la superficie del conduttore grosso. Poiché
le frequenze più basse sono meno soggette all’”effetto pelle”, esse viaggeranno
ovunque in tutti i conduttori. Vi è un certo disaccordo in merito
all’”effetto-pelle” e le sue conseguenza pratiche sulle frequenze audio, ovvero
se esso causa danni diversi da quello di una semplice perdita di potenza.
Tuttavia, i problemi sono reali ed udibili. Questi sono dovuti al fatto che –
ancor prima della perdita di potenza - l’”effetto pelle” provoca variazioni nei
valori di resistenza ed induttanza. Questi valori tenderanno a mutare
continuamente a seconda della distanza dalla superficie del conduttore. Se la
sezione di un cavo sarà troppo grande, l’”effetto pelle” inciderà anche sulle
frequenze audio riprodotte. Le delicate informazioni ad alta frequenza, la parte
superiore delle armoniche, saranno appiattite, “spalmate”, con un suono ottuso,
dai dettagli troncati ed una scena acustica carente.
Equivoci e trucchi
Se un cavo di potenza utilizza un unico filo di rame da 0,8 millimetri, potrebbe
avere un valore resistivo troppo elevato per svolgere la propria funzione in
modo corretto. Le sensibilità degli speakers variano, ma se il percorso tra
l'altoparlante e amplificatore presenta una resistenza eccessiva, la qualità del
suono ne risentirà. Tale degrado non è da addebitare alla distorsione nel cavo,
ma alle dimensioni troppo ridotte di esso. Per questo motivo, anche un cavo di
metraggioi dovrebbe essere di almeno 18 AWG (.82 sq mm) o più grande. La perdita
di potenza causata dalla resistenza non è – di solito - un problema
significativo. Un cavo molto sottile può a causare il 10% di perdita di potenza,
con il risultato di abbassare il volume di una frazione di decibel. Se un
segnale è stato privato delle informazioni che consentono di percepire il
contrasto dinamico, la bellezza delle armoniche, la raffinatezza tonale,
tendiamo a fare riferimento ad una perdita in "ampiezza". In realtà, il segnale
riprodotto in modo piatto e privo di mordente a causa di un cavo assai
deficitario, e non perché provochi una perdita di potenza, ma a causa della
distorsione che aggiunge.
Qualche parola sui cavi multifilari
Giacché un buon cavo per diffusori deve possedere più metallo rispetto ad un
singolo filo da 0.8 mm (20 AWG), la sfida AudioQuest è quella di fornire un
miglior percorso elettrico al segnale senza introdurre nuovi problemi. Se
prendiamo un certo numero di fili di rame (strand) e li raggruppiamo in un
fascio, l’intero fascio andrà soggetto all’”effetto pelle”. I fili più esterni
presenteranno un passaggio elettrico ideale, ma quelli all’interno avranno dei
valori elettrici differenti. Avviene pertanto che la stessa informazione che
transita attraverso il cavo venga distorta in modo differente in punti
differenti del cavo stesso. Più è grosso il fascio di fili, più è grande il
problema. Se raggruppare in fascio i singoli fili consente di abbassare la
resistenza, poi bisogna però contenere le dimensioni del fascio. Può accadere
che sia necessario considerare parecchi fasci separati. Ci sono molti modi nei
quali l’”effetto pelle” può causare più distorsione in un fascio, piuttosto che
in un singolo conduttore sovradimensionato. I conduttori filari cambiano
costantemente di posizione lungo il percorso del cavo. Alcuni dalla superficie
si dirigono verso l’interno; altri “emergono” in superficie. Dato che la densità
del flusso elettrico distribuita in un conduttore non può cambiare, una parte
del flusso (particolarmente alle frequenze più alte) deve continuamente saltare
su un nuovo conduttore per raggiungere la superficie o la sua prossimità.
Purtroppo il contatto tra i fili di rame è men che perfetto. Il punto di
contatto tra questi corrisponde esattamente ad un circuito che ha capacità,
induttanza, diodi di rettificazione; un mucchio di problemi insomma. E ciò
accade migliaia di volte nella lunghezza del cavo ed è causa della maggior parte
delle sgradevolezze acustiche riscontrabili da essi. Il meccanismo di questa
distorsione è dinamico, estremamente complesso e, per colpa dell’ossidazione,
questa andrà peggiorando nel tempo.
Interazione magnetica
L’interazione magnetica è l’altro problema primario che affligge la
progettazione di cavi, a prescindere dal tipo di conduttore. Un conduttore, un
filo che trasporta corrente, è circondato da un campo magnetico. In un fascio,
ogni filo ha il suo campo magnetico. Questi campi magnetici interagiscono
dinamicamente con il mutare del segnale. A livello microscopico, un cavo con
conduttore multi filare è fisicamente modulato dal fluire della corrente che
scorre al suo interno. I campi magnetici più potenti sono associati alle note
basse e creano le interazioni magnetiche più importanti, le quali modulano le
caratteristiche elettriche del cavo che, a sua volta, modula le frequenze più
alte. A causa di ciò, il segnale musicale modula la pressione di contatto tra i
fili adiacenti, e contemporaneamente modula la distorsione generata dalla
corrente, che passa da un conduttore all’altro.
Ridurre l'interazione magnetica è la ragione principale per cui il pilotaggio
biwiring dei diffusori è particolarmente efficace. Le casse bi-wiring hanno
ingressi separati per i bassi e gli alti, che consentono l’accesso alle due metà
del "crossover". Un crossover è semplicemente un filtro passa-basso che consente
all’energia in bassa frequenza di raggiungere il woofer, mentre il filtro passa
alto permette alle alte frequenze di passare al tweeter o al midrange. Questi
filtri bloccano i segnali indesiderati causando all'amplificatore la percezione
di una impedenza infinita sulle frequenze di taglio. Dato non vi è alcun
circuito chiuso a quelle frequenze, la corrente nel cavo, non viaggia a queste
frequenze come in una lampadina che non si illumina quando l'interruttore
elettrico è spento, non importa quanti megawatt siano disponibili. Tenendo il
cavo delle alte frequenze lontano da quello che porta bassi, non compromette la
resa dei bassi. Però, tenendo separate le basse frequenze dal cavo che convoglia
le frequenze superiori, si ottiene un sensibile miglioramento. Il campo
magnetico associato alle frequenze basse non può più interagire e distorcere con
quelli prodotti dalle frequenze medio/alte. Mentre le note basse fondamentali
non risentono del bi-wiring, le armoniche delle basse più elevate gioveranno di
un miglioramento, venendo riprodotte dal midrange. Le armoniche definiscono i
toni bassi e la descrizione dello strumento che le ha create. Acne se noi
potessimo assicurare un’assoluta rigidità meccanica nei cavi multifilari,
l’interazione tra campi magnetici rimarrebbe, comunque, la primaria fonte di
distorsione. La corrente che scorre all'interno di un conduttore è direttamente
proporzionale al campo magnetico al di fuori del conduttore. Nella maggior parte
dei cavi, il campo magnetico di ogni sezione incontra una complessa e mutevole
serie di interazioni che viaggia attraverso una costante evoluzione del campo
magnetico. Come il campo magnetico è modulato, il segnale audio diventa confuso
e distorto. La causa di distorsione è dovuta sia all’interazione magnetica, sia
dal contatto tra i singoli fili nudi. AudioQuest ha trovato una soluzione a
tutto questo denominata Semi-Solid Concentric-Packing. I conduttori sono solidi,
fasciati singolarmente e quindi associati strettamente assieme intorno ad un
conduttore centrale.
Qualità dei materiali
La qualità dei materiali interessa sensibilmente le prestazioni dei cavi e delle
relative terminazioni. Dobbiamo considerare sia l’intrinseca qualità del
metallo, come l’oro, il nickel, l’ottone, l’alluminio, il rame, l’argento, sia
il modo in cui questi sono stati lavorati e rifiniti. L’argento puro è il
migliore materiale per l’audio, il video ed il segnale digitale. Però, se
l’argento non è trattato con la dovuta accuratezza, anche il rame di più basso
grado di purezza può suonare meglio. L’argento si è guadagnato una confutabile
reputazione basata sull’equivoco del termine “silver”, laddove questo sta ad
intendere rame “silver-plated”, placcato argento. Con i segnali audio analogici,
il rame argentato può produrre un suono molto irritante, come avere un tweeter
sparato sul viso. In altre applicazioni, vedi con segnali video, RF o digitale,
del buon rame argentato diviene estremamente valido, superando in prestazioni
anche il rame di più alta qualità. Perché non l’oro? Perché l’oro non ha né
bassa distorsione, né bassa resistenza. E’ utilizzabile nei connettori in virtù
della sua “nobiltà”, non essendo esposto a fenomeni di corrosione e per questo
utile a proteggere materiali più vulnerabili, come il rame e l’ottone. La natura
tonale della distorsione dell’oro è piacevole e calda, e si fa preferire
all’irritante impronta sonica del nickel. Un componente in nudo rame, od ottone,
è superiore ad uno placcato oro, ma solo fino a quando questi non sarà soggetto
a corrosione. Al confronto, un componente in spesso rame argentato di alta
qualità, migliorerà sensibilmente le prestazioni. L’argento non è nobile come
l’oro, ma è comunque refrattario alla corrosione e migliora le prestazioni. Il
primo grado sopra il rame standard di alta purezza è l’Oxygen-Free
High-Conductivity (OFHC). In realtà, questo rame non è totalmente Oxygen-Free,
la denominazione più corretta dovrebbe essere “Oxygen-Reduced”. Il suono di un
cavo OFHC è più raffinato, pulito e dinamico rispetto all’omologo in rame
standard ad alta purezza.
L’importanza della geometria del cavo.
Anche il rapporto esistente tra i conduttori riveste un aspetto importante. Se
questo rapporto non è coerente, i parametri elettrici (quali capacità e
induttanza) cambiano costantemente ed il segnale sarà distorto. I conduttori
all’interno di un cavo possono assumere diversi assetti geometrici: parallelo,
spiralato (twisted), intrecciato. Queste varie geometrie hanno conseguenti
prerogative. La produzione del cavo con geometria del conduttore parallela è
economica; quello spiralata ha buona reiezione delle RFI e, di norma, induttanza
più bassa. Quello intrecciata oppone resistenza alle RFI, ha bassa induttanza,
ma soffre delle conseguenze derivanti dal continuo cambio dei valori elettrici
di ogni conduttore. Un cavo può avere due o più conduttori. L’assetto di questi
conduttori determina l’interazione magnetica, la capacità, e l’induttanza dello
stesso. Entrambi, capacità e induttanza, causano un preventivabile e misurabile
effetto “filtro”, e un progressivo aumento dello slittamento in fase delle
frequenze più elevate. L’effetto della capacità è qualcosa di simile ad una
scogliera; puoi andare vicino all’orlo del precipizio, ma non andare oltre.
Esiste, nell’applicazione pratica, un valore oltre il quale la capacità diventa
un problema. Con un valore più basso ci si allontana dall’orlo della scogliera e
avere senza grandi limitazioni. D’altro canto, l’induttanza è sempre un problema
e ne accumula continuamente. Comunque, capacità e induttanza non sono le uniche
variabili nella progettazione di un cavo. Vanno pertanto studiati modelli che
abbiano una capacità che non si spinga “oltre la scogliera” e,
contemporaneamente, presenti un’induttanza minima. Una teoria sulla
progettazione dei cavi vuole che il valore dell’impedenza di un cavo debba
abbinarsi a quella del carico del diffusore acustico. L’abbinamento tra
impedenze è un concetto valido e si applica soltanto quando l’impedenza della
sorgente, del cavo e il carico sono tutte le stesse, e quando il cavo è più
lungo di una lunghezza d’onda delle frequenze da trasmettere. Gli amplificatori
non hanno impedenze d’uscita di 4 o 8 ohm; per questo i progettisti puntano ad
avere i valori più bassi possibili. I diffusori differiscono l’uno dall’altro, e
cambiano impedenza al variare della frequenza. Si dovrebbe realizzare un valore
di capacità molto elevato (oltre l’orlo della scogliera) per avere il necessario
corollario per una bassa impedenza, ma una così alta capacità comprometterebbe
in maniera severa la prestazione di un’amplificazione e questa condizione va
evitata.
Il “rodaggio” dei cavi
Come per tutti gli altri componenti audio, anche i cavi richiedono un periodo di
“rodaggio” o “assestamento”. Questo lasso di tempo è erroneamente chiamato
“break-in”. Il termine è più corretto in ambito meccanico, relativo ad un
motore, o, per l’audio, all’assestamento delle sospensioni degli altoparlanti o
del cantilever di una testina fonografica. Le prestazioni di un cavo raggiungono
il loro optimum quando il comportamento del dielettrico (ovvero il modo in cui
il materiale isolante di un cavo assorbe e rilascia energia) cambia in presenza
di una carica elettrica. Il cavo in “rodaggio” continuerà a migliorare in
qualità sonora - o visuale - per un periodo che può arrivare anche a parecchie
settimane. Per questa stessa ragione anche amplificatori, preamplificatori e
lettori CD richiedono un periodo di assestamento. Non usando un cavo per diverse
settimane, questi tenderà a tornare al suo stato originale. Il tempo di
assestamento di un cavo è più o meno lo stesso per tutti i modelli, anche se,
apparentemente, la necessità di “rodaggio” può variare grandemente. Pertanto, si
dovrà mettere in preventivo una buona dose di pazienza durante i primi ascolti
di qualsiasi nuovo prodotto di classe superiore.
Direzionalità dei cavi
Tutti i cavi sono direzionali, da quello per elettricisti al più puro dei cavi
in argento. Tutti i cavi AudioQuest sono marcati per direzionalità. Con altri
cavi potrebbe essere sufficiente ascoltarli in una direzione, poi nell’altra. La
differenza apparirà chiara nella direzione corretta: in questa la musica fluirà
più rilassante, piacevole e credibile. Se invece questo non succederà, o non
sarà chiaramente identificabile, potrà dipendere dal fatto che la struttura
molecolare dell’estrusione metallica non è simmetrica, fornendo una spiegazione
fisica all’esistenza della direzionalità.
Come ottenere il meglio dai propri cavi
Alcuni produttori di cavi fortemente orientati al marketing sottolineano, prima
di altri aspetti, l’importanza dei connettori e delle terminazioni. E’ un grave
errore pensare che i connettori (e la loro estetica) siano più importanti del
cavo stesso, ma sarebbe un errore anche ignorare la connessione d’interfaccia.
AudioQuest dedica una parte speciale del proprio catalogo a questo tipo di
prodotto. I connettori danno un importante contributo alla performance,
soprattutto quelli RCA e XLR. Per i cavi di potenza, i tipi di terminazione sono
un po’ più complicati, ma solo perché ci sono più equivoci su priorità molto
semplici da osservare. Il miglior tipo di connessione è il cosiddetto tipo
“sottovuoto” (“gas-tight” o “cold-weld”), che consente di ottenere un affidabile
e costante contatto tra le superfici del connettore e del conduttore, formando
un “unicum” di notevole robustezza ed efficacia.
Segnali buoni e segnali cattivi
In queste pagine abbiamo spiegato come il segnale elettrico possa tentare di
attraversare il conduttore metallico con le minori interferenze e cambiamenti
possibili. Purtroppo c’è spesso un segnale che scorre nei cavi che non dovrebbe
esserci. C’è un’intera categoria di energia riferita alle RFI (Radio Frequency
Interference); quando queste entrano in un sistema audio compromettono le
prestazioni dei componenti e quindi il suono e/o l’immagine. Spesso si ritiene
che se non si sente una trasmissione radiofonica provenire dal lettore CD, non
si hanno RFI. Questo non è necessariamente vero. Per captare una sorgente radio,
senza avere un tuner, deve accadere che una sezione del sistema di riproduzione
colga una particolare frequenza radio, rettificandola in una frequenza audio. La
maggior parte delle RFI non sono demodulate in segnale audio. Questo è un
rischio concreto e proviene dall’energia ad alta frequenza prodotta da
apparecchi radio e TV, forni a microonde, radar, baracchini CB e centinaia di
altre sorgenti, incluse quelle del proprio impianto stereo o A/V. I lettori CD
devono essere registrati, come fonti di RFI, presso l’FCC (Federal Communication
Commission), lo stesso vale per i sintonizzatori, per i TV ed i computers. Il
problema delle RFI non è certo nuovo e nemmeno di facile soluzione. Per decenni,
i progettisti hanno usato anelli di ferrite attorno ai cavi per bloccare
l’accesso alle RFI. La ferrite riduce le RFI in un cavo interrompendo le
componenti a frequenze radio del campo magnetico all’esterno del cavo. Ad una
corrente che viaggia all’interno di un cavo, deve essere associato un campo
magnetico esterno. Alterando il campo magnetico, la ferrite è in grado di
filtrare la corrente nel cavo senza che nulla venga inserito all’interno di
esso. Vanno evitate soluzioni poco efficaci che introducono altri problemi, come
connessioni o stadi elettronici aggiuntivi. Gli RF Stoppers nei cavi di
alimentazione dei refrigeratori riducono, ma non eliminano, il problema. Questi
filtrano molto bene le frequenze molte alte e pertanto non sono da usare nei
cavi digitali o video.
Metodologia di valutazione
C’è una fondamentale distinzione tra ascolto della musica e ascolto
dell’impianto. Questo è senza dubbio uno dei motivi di riflessione più diffuso
all’interno dell’industria audio. Come si può giudicare la validità di un
veicolo senza provarlo? L’esatta definizione di un buon sistema audio è la sua
capacità di diventare “invisibile”. Deve gradualmente scomparire lasciando lo
spazio al suono. Osservando un paesaggio lontano attraverso i vetri di una
finestra, sarà apprezzabile il fatto che questi siano puliti e non distorceranno
la visione. Un test valido sarebbe quello di determinare quanta interferenza
causano i vetri della finestra; ma sarebbe assolutamente improduttivo
focalizzarsi su i vetri in sé per sé. Focalizzarsi sullo sporco del vetro fa
dimenticare la bellezza del panorama. Per questo è importante evitare il rischio
di appuntare la nostra attenzione sul sistema in sé, dimenticando di giudicare
le sue reali capacità e attitudini in fatto di musica. Nel processo di
valutazione, separare un sistema di riproduzione audio dalla funzione per cui è
nato è il più grande errore che si possa commettere. A dispetto degli
imperversanti “orecchi d’oro” e similari, è di norma l’ascoltatore neofita a
cogliere più nettamente le differenze e a stabilirne l’importanza. Sono proprio
gli appassionati privi di esperienza di ascolto e di conoscenze tecniche ad
andare direttamente al concreto. Comunque, anche questa gente fortunata ha
bisogno di un contesto appropriato per cogliere l’essenza della realtà acustica.
Esistono però dei rischi anche per gli orecchi vergini. La sfida per la maggior
parte di noi, immersi in questo favoloso mondo, è recuperare l’innocenza della
prima volta in cui abbia provato l’emozione nell’ascoltare un sistema audio
migliore di quanto ce lo aspettassimo. Generalmente, questa capacità critica si
sviluppa nella tarda adolescenza, poi nel corso della nostra vita tendiamo a
ricreare le condizioni di quell’esperienza. La cruciale distinzione è tra
“evento” ed “esperienza”. Il paradigma politicamente corretto nell’audio è
essere occupati nel ricreare un evento accaduto in uno spazio ed un tempo
diversi. La musica e i dati tecnici son cose diverse. Se la registrazione e la
riproduzione sono avvenuti in modo perfetto, musica e tecnica sono state
equamente onorate. Comunque, i sistemi audio sono ben lungi dall’essere
perfetti. Questa grande discrepanza lascia spazio ad alcune priorità, tra cui
quella che chiameremmo “tirannia della risoluzione percepita”. Per esempio:
comparando due componenti, uno riproduce in modo molto convincente un quartetto;
ma l’altro rivela che questi, in realtà, è un quintetto. Sarebbe formalmente
corretto dichiarare immediatamente superiore quell’apparecchio. Se però il suono
del “quartetto” è coinvolgente ed appassionante, mentre quello del “quintetto” è
affaticante ed irritante? Non è più importante la godibilità della musica?
Questa dicotomia esalta le ragioni per cui un sistema progettato per il
monitoraggio di una sessione di registrazione è spesso così differente da un
sistema di intrattenimento domestico. L’alta capacità di risoluzione è la
funzione principale di un sistema di monitoring; suonare bene ed essere godibile
hanno poco valore; ascoltare cosa sta succedendo durante la registrazione è ciò
che importa. Inoltre, il pericolo di ascoltare l’impianto anziché la musica è
fondamentale sfida nella valutazione pratica. E’ stupefacente l’abilità umana
all’adattamento; noi siamo formidabilmente capaci di vedere attraverso la
distorsione. Generalmente, non “avvertiamo” i nostri indumenti, ma sentiamo
anche solo una goccia di pioggia cadere su i nostri abiti. Possiamo indossare
occhiali da sole di tutti i colori e continuate a vedere il cielo blu. Se
usassimo occhiali protettivi gialli mentre sciiamo in una giornata nuvolosa,
quando li toglieremmo potremmo vedere la neve viola. La soluzione non è
“togliere” la vernice gialla dalla neve, ma – semmai – ricalibrare a nostra
volta i nostri riferimenti
SCHEMI CONNETTORI

Connettore xlr
Linea bilanciata
Una linea bilanciata o simmetrica in elettrotecnica indica una connessione atta
a trasportare segnali analogici, solitamente di bassa potenza, da
un'apparecchiatura ad un'altra. Viene definita simmetrica in quanto i due
conduttori e i relativi morsetti di collegamento sono nelle medesime condizioni
elettriche rispetto alla terra.In alcune applicazioni, un terzo morsetto
costituisce il collegamento di schermo, ovvero una calza costituita da fili
metallici intrecciati che avvolge i fili della linea.Si distingue dalla linea
sbilanciata o asimmetrica, che è invece quella in cui i due conduttori non sono
nelle medesime condizioni elettriche (come ad esempio un conduttore coassiale,
nel quale il conduttore esterno risulta collegato a terra
Principio di funzionamento
Modello di linea bilanciataIl bilanciamento è ottenuto terminando la linea su un
trasformatore a presa centrale, così che i disturbi di modo comune, che
percorrono i due conduttori nello stesso verso, diano origine sul trasformatore
a due flussi uguali (ma di segno opposto). In questo modo la loro somma sarà
idealmente nulla e il disturbo verrà totalmente annullato. Nella realtà, i due
flussi saranno certamente di segno opposto, ma non propriamente uguali, così che
rimarrà sempre un disturbo residuo (seppur minimo).L'accoppiamento tramite un
trasformatore può essere fatto anche all'ingresso della linea. In questo modo è
possibile minimizzare anche i disturbi di modo comune che percorrono la linea
verso la sorgente.
Audio
Nel campo dell'audio professionale si impiegano sia linee bilanciate che
sbilanciate, ma è preferita la linea bilanciata, essendo meno influenzata da
eventuali disturbi esterni, specialmente se il percorso del cavo è di parecchi
metri. Linee bilanciate vengono usate soprattutto per collegare i microfoni al
mixer, talvolta fornendo anche l'alimentazione phantom usando lo stesso cavo. I
microfoni, infatti, presentano di solito una bassa impedenza di uscita, che
rende la linea suscettibile ai disturbi.Impianti audio di livello domestico
usano di solito, invece, linee sbilanciate.Una linea bilanciata può essere
impiegata anche per portare un segnale stereofonico usando i due conduttori come
i poli caldi di due linee sbilanciate, oppure per trasferire un segnale
bidirezionalmente su uno stesso cavo, sempre utilizzando la linea bilanciata
come due linee sbilanciate: è questo il caso, molto comune sui mixer, del
cablaggio in insert di effetti o compressori.I connettori adottati sono
standardizzati da decenni: per le linee bilanciate si adotta il tipo XLR o
Cannon a tre poli, oppure Jack stereo (3 poli), mentre per le linee sbilanciate
si usa il tipo RCA oppure Jack mono (2 poli). Da notare che collegando insieme
il polo freddo e la massa di una linea bilanciata, si ottiene una linea
sbilanciata costituita dai due conduttori collegati insieme e dal polo caldo.
Questo è di uso molto comune anche in campo professionale per collegare diversi
tipi di apparecchiature tra di loro, anche se sarebbe più corretto l'uso di un
balun o di un traslatore.
 Pin1
--> Xternal of cable (shield/ground) Pin2 --> Live (“Hot” /+ polarity)
Pin3 --> Return (“Cold” /- polarity) Pin1
--> Xternal of cable (shield/ground) Pin2 --> Live (“Hot” /+ polarity)
Pin3 --> Return (“Cold” /- polarity)
 
Connettore DIN
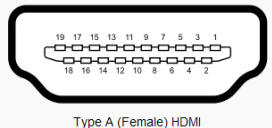
.jpg)

Connettore HDMI
Pin 1 TMDS Data2+
Pin 2 TMDS Data2 Shield
Pin 3 TMDS Data2–
Pin 4 TMDS Data1+
Pin 5 TMDS Data1 Shield
Pin 6 TMDS Data1–
Pin 7 TMDS Data0+
Pin 8 TMDS Data0 Shield
Pin 9 TMDS Data0–
Pin 10 TMDS Clock+
Pin 11 TMDS Clock Shield
Pin 12 TMDS Clock–
Pin 13 CEC
Pin 14 Reserved (N.C. on device)
Pin 15 SCL
Pin 16 SDA
Pin 17 DDC/CEC Ground
Pin 18 +5 V Power (max 50 mA)
Pin 19 Hot Plug Detect
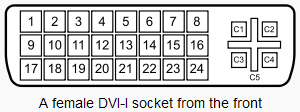
Connettore DVI-I
Pin 1 TMDS Data 2- Digital red -
(Link 1)
Pin 2 TMDS Data 2+ Digital red + (Link 1)
Pin 3 TMDS Data 2/4 shield
Pin 4 TMDS Data 4- Digital green - (Link 2)
Pin 5 TMDS Data 4+ Digital green + (Link 2)
Pin 6 DDC clock
Pin 7 DDC data
Pin 8 Analog vertical sync
Pin 9 TMDS Data 1- Digital green - (Link 1)
Pin 10 TMDS Data 1+ Digital green + (Link 1)
Pin 11 TMDS Data 1/3 shield
Pin 12 TMDS Data 3- Digital blue - (Link 2)
Pin 13 TMDS Data 3+ Digital blue + (Link 2)
Pin 14 +5 V Power for monitor when in standby
Pin 15 Ground Return for pin 14 and analog sync
Pin 16 Hot plug detect
Pin 17 TMDS data 0- Digital blue - (Link 1) and digital sync
Pin 18 TMDS data 0+ Digital blue + (Link 1) and digital sync
Pin 19 TMDS data 0/5 shield
Pin 20 TMDS data 5- Digital red - (Link 2)
Pin 21 TMDS data 5+ Digital red + (Link 2)
Pin 22 TMDS clock shield
Pin 23 TMDS clock+ Digital clock + (Links 1 and 2)
Pin 24 TMDS clock- Digital clock - (Links 1 and 2)
C1 Analog red
C2 Analog green
C3 Analog blue
C4 Analog horizontal sync
C5 Analog ground Return for R, G and B signals

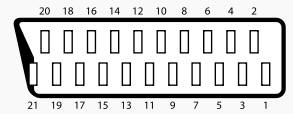
CONNETTORE SCART
Syndicat des Constructeurs d'Appareils
Radiorécepteurs et Téléviseurs, ovvero Sindacato dei Costruttori di Apparecchi
Radioricevitori e Televisori.
Con SCART si intende in genere sia il cavo SCART che la presa SCART, sebbene
ovviamente in certi casi sia necessario specificare di cosa si stia parlando, ai
fini della chiarezza del discorso. La presa SCART è un particolare tipo di
connettore utilizzato nei televisori e negli apparecchi che ad esso devono
essere collegati, come videoregistratori, decoder, Lettori DVD e DVD-recorder.La
presa è dotata di 20 piedini (detti anche poli o "pin"), ognuno dei quali
veicola un segnale elettrico analogico, che può uscire o entrare nella presa
SCART. Il bordo metallico della presa e del cavo che ad essa si connette funge
da ventunesimo contatto, e veicola la massa della schermatura.Il connettore
SCART può venir definito, piuttosto raramente, anche connettore Peritelevisione
(dal francese Péritel) o Euroconnettore
PIEDINATURA
Pied.1 Uscita audio (destra)
Pied.2 Ingresso audio input (destro)
Pied.3 Uscita audio (sinistra o mono)
Pied.4 Massa audio
Pied.5 Massa blu RGB (massa pied. 7)
Pied.6 Ingresso audio (sinistro o mono)
Pied.7 Ingresso blu RGB o
Ingresso C S-Video1)o
Uscita Pb Componente2)
Pied.8 Uscita stato e Aspect ratio3) [0-0,4V → spento, 5-8V → 16:9, 9,5-12V →
acceso o 4:3]
Pied.9 Massa verde RGB (massa pied. 11)
Pied.10 Sincronismo / Dati 24)
Control bus (AV.link)
Pied.11 Ingresso verde RGB o
Uscita Y Componente2)
Pied.12 Riservato / Dati 14)
Pied.13 Massa rosso RGB (massa pied. 15)
Pied.14 Massa piedini 12 e 16
Pied.15 Ingresso rosso RGB o
Uscita C S-Video o
Uscita Pr Componente2)
Pied.16 Segnale di Blanking
Commutazione RGB voltaggio [0-0,4V → composito, 1-3V → RGB]
Pied.17 Massa uscita video composito (massa pied. 19)
Pied.18 Massa ingresso video composito (massa pied. 20)
Pied.19 Uscita video composito o
Uscita Y S-Videot
Pied.20 Ingresso video composito o
Ingresso Y S-Video
Pied.21 Massa piedini 8 e 10
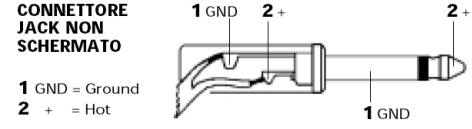
CONNETTORE JACK
.gif) 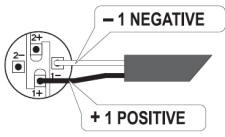
CONNETTORE SPEAKON
Il connettore Speakon è un tipo
di connettore spesso usato nei sistemi di audio professionale per connettere un
altoparlante ad un amplificatore. Lo stesso produttore produce un altro tipo di
connettore PowerCon, che è stato progettato per supportare potenze maggiori del
normale segnale audio. Per maggiore sicurezza, il segnale audio e
l'alimentazione non sono connessi tra di loro.Il connettore Speakon è stato
progettato con un sistema di bloccaggio che può essere utilizzato per
connessioni con saldatura o ad avvitamento.
.jpg) 
|